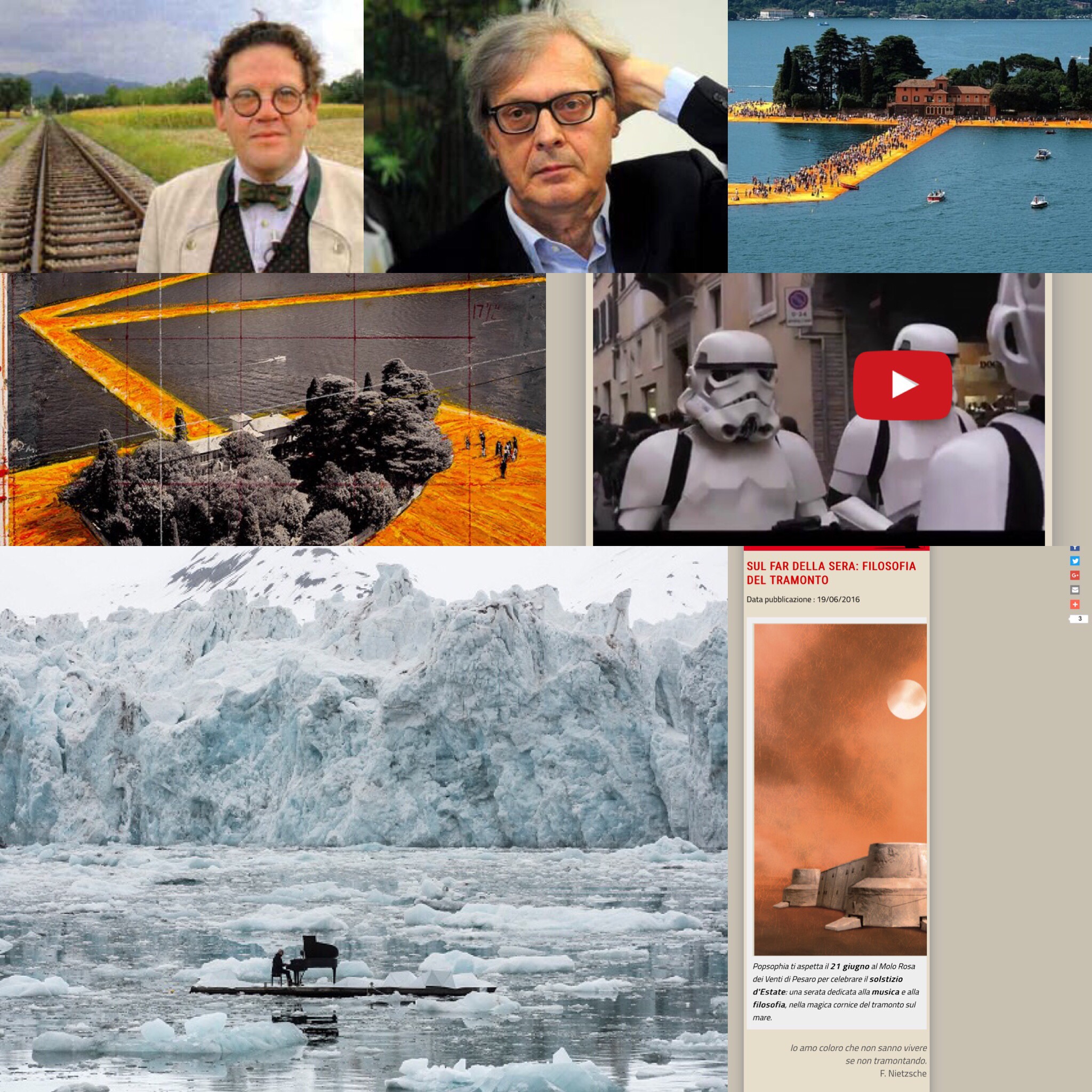Oggi assistiamo ad una tecnica che opprime un uomo dalla debole capacità difensiva: essendo egli capace di provare comunque atteggiamenti ‘sentimentali’, piuttosto che continuare ad amare i segreti della natura, rimane affascinato dalla tecnica e dalla tecnologia.
Non si fa solo riferimento al fenomeno dell’industrializzazione, ma anche a tutti quei mezzi tecnici diventati popolari come la televisione, i giornali, la pubblicità, e tutto ciò che rientra nella comunicazione. “Molto spesso tanto la TV che i cinegiornali e le inchieste filmate si avvalgono di spettacoli ricostruiti e truccati ma spacciati “per veri”; o, al contrario, di veri ma spacciati per artificiali (o di cui si lascia credere che lo siano). Le cronache dei nostri giornali ne sono colme: basta assistere al più modesto e innocente spettacolo per avvedersene: le smorfie d’imbarazzo, l’impaccio, la confusione d’un personaggio interrogato ad un “quiz” sono vere o false? Lo spettatore di solito partecipa con giubilo, con acuto e morboso interesse, a tali manifestazioni (dopotutto di sofferenza morale), proprio perché è convinto di assistere all’autentica situazione d’un uomo che si dibatte di fronte a domande insidiose” (Dorfles Gillo, Artificio e natura, Torino, p.45-46). “In tutte queste trasmissioni, dunque, siamo posti di fronte ad un tipico caso di contraffazione della naturalità; ossia assistiamo – e ce ne compiacciamo – ad un episodio reale ma provocato ad arte (e per di più con fine malizioso)” (Dorfles Gillo, op. cit., p.46). Il risultato è il dilagare di un fenomeno che conduce gli osservatori ad uno scetticismo nei confronti dell’informazione o del semplice intrattenimento a cui, pur essendo consapevoli della loro ambigua realtà, sono assuefatti.
Con questo non si vuole intendere negativamente l’uso degli strumenti mediatici, semplicemente è preferibile rendersi conto quanto di un prodotto che ci viene proposto attraverso i media tecnologici sia autentico e quanto non lo sia, o si presume non lo sia.
Si dovrà dare conferma a quanto detto prima: cioè la crisi dell’umanismo è legata alla perdita della soggettività umana nei meccanismi dell’oggettività scientifica e poi tecnologica. Questo particolare rapporto dell’uomo con la macchina (o la tecnica) è contornato di un alone di minaccia, per cui il pensiero deve rendersi cosciente delle distinzioni che il mondo umano dà dell’oggettività tecnica, sforzandosi di riappropriarsi della propria centralità.
Nel capitolo precedente abbiamo potuto osservare come idea e manualità fossero i principi caratterizzanti e riconducibili all’essere umano. Ma, oggi, l’azione e la meccanicità dove conducono l’uomo? La macchina potrebbe essere una risposta, in tutte quelle forme di tecnologia che hanno profondamente caratterizzato il nostro tempo. Queste ultime hanno insegnato all’uomo a vivere nell’azione, viceversa l’uomo non è mai riuscito a trasferire loro (in senso artistico) l’idea e la creatività autonome.
La macchina ha fatto sì che l’uomo perdesse la propria manualità (istintiva caratteristica della creatività), imponendogli di ragionare secondo una logica tecnica secondo cui l’azione prevale sul pensiero ed è capace di attingere dalla verità e dall’assoluto. L’azione della tecnica ha portato a delle conquiste, ma anche a distruzioni; le scoperte che hanno portato all’energia nucleare hanno condotto anche alla morte: il suo duplice aspetto può far godere i benefici del suo progresso oppure portare a morte e distruzioni, e non necessariamente in senso materiale.
Ma non è solo in tale senso catastrofico che in questo discorso s’intende parlare dell’azione della tecnica come fine dell’evoluzione creativa dell’uomo. Anche se l’incombere di una possibile distruzione atomica è evento reale, viene considerata come un elemento caratteristico di questo nuovo modo di vivere l’esperienza nell’era post-moderna, la cui azione non è del tutto negativa. Si pensi a quanti progressi essa ha apportato al genere umano e a quanti benefici non avremmo neppure immaginato di godere. Si può affermare che le esperienze dell’uomo si muovono di moto perpetuo, e come in precedenza è stato affermato: “la vita è esperienza, la ripetizione è arresto di esperienza”, (Argan C.G. op. cit.p.,26) quindi morte.
Ciò che caratterizza un epoca viene sostituito da altro nella successiva. Definire oggi l’azione della tecnica come un qualcosa a noi estraneo significherebbe vivere chiudendo gli occhi alla realtà, oltre al fatto che sarebbe un’ipocrisia imputare ad essa tutte le colpe dei mali della società contemporanea. Un possibile rimedio potrà realizzarsi quando si attuerà un processo di ‘naturalizzazione’ della macchina, considerarla ‘natura’ alla stessa stregua di come lo furono ieri gli ‘animali’ e le ‘piante’. “Si tratta cioè di considerare “natura” non più soltanto la natura allo stato selvaggio oggi sempre più rara e irraggiungibile – ma anche queste nuove forme di natura meccanizzata o elettronicamente integrata. In altre parole: occorre che le costruzioni artificiali dell’uomo – sia che appartengono alle manipolazioni manuali che un tempo spettavano all’artigiano (e alle altre arti), sia che appartengano ai prodotti diretti della meccanica, sia che si tratti, non già di prodotti tangibili, ma di forme di pensiero, di immagini – vengano ad un certo punto “rettificate”; subiscano quel processo di naturalizzazione che solo può conferirgli una nuova valenza creativa” (Dorfles Gillo, op. cit. p., 27).
Queste affermazioni potranno apparire paradossali, soprattutto per la posizione dell’uomo oggi che deve saper convivere con queste nuove forme di ‘natura’. È lui che dovrà essere in grado di compiere una determinante azione sulla tecnica, e non il contrario. Non sappiamo quello che il futuro rivelerà, ma sappiamo che la misura che determina il progresso della tecnica scorre più rapidamente rispetto al tempo di adattamento dell’uomo, e da questo possiamo notare come ‘l’onnipresente’ macchina sia già stata sostituita dal ‘mimetico’ circuito; quest’ultimo, in futuro, sicuramente cederà il suo posto.
In conclusione si può affermare, considerato che l’essere umano è dotato di una intelligenza progressiva, che l’’Homo Sapiens’, in quanto tale, deve affrontare il continuo progresso cosciente della propria esperienza plurisecolare, non vivendo di paure e timori di ciò che egli stesso ha creato.
Marco Santoro